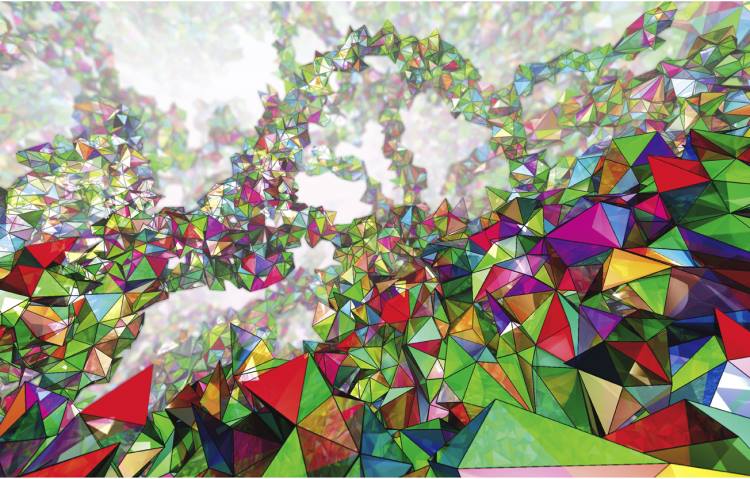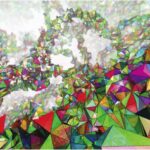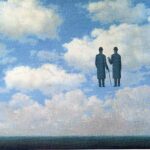Una prospettiva fenomenologica
Quando mi chiedono “cos’è il genere?”, la mia risposta si allontana dalle definizioni più comuni. Per molti, il genere è una “costruzione sociale”, un insieme di regole e aspettative che la società ci impone. Nella mia ricerca, e nella mia visione, il genere è qualcosa di molto più profondo e radicato: è un’esperienza che si incarna nel nostro corpo e prende forma nelle nostre relazioni.
Il mio percorso, che affonda le radici nella filosofia neofenomenologica, mi porta a esplorare il genere come un fenomeno dinamico e profondamente umano, ispirandomi a pensatrici come Iris Marion Young e Federica Giardini.
Il corpo al centro: il genere è un’esperienza incarnata
Il punto di partenza della mia riflessione è sempre il corpo. La Fenomenologia Femminista, che guida il mio approccio, ci insegna a non pensare al genere come a un’etichetta astratta, ma come a un’esperienza che “viviamo” attraverso il nostro corpo.
Non si tratta solo di come la società ci definisce, ma di come noi sentiamo e percepiamo il nostro essere nel mondo. I nostri gesti, il nostro modo di muoverci e di occupare uno spazio, come ha brillantemente descritto Iris Marion Young, sono parte integrante della nostra identità di genere. Il genere, quindi, non è un ruolo che recitiamo, ma un’esperienza che si manifesta e si modella nel nostro corpo, giorno dopo giorno.
La “Paarung”: il genere nasce nella relazione
Se il corpo è il punto di partenza, la relazione è il campo in cui il genere prende vita. Un concetto per me fondamentale è quello di “Paarung”, un termine del filosofo Husserl, riletto in modo illuminante da Federica Giardini, che possiamo tradurre come “appaiamento” o “risonanza relazionale”.
La “Paarung” suggerisce che noi esseri umani siamo naturalmente predisposti alla relazione con l’altro, in una dimensione che è innanzitutto corporea e sessuata. È una sorta di connessione che precede le parole e le norme sociali. È proprio questa “risonanza” il cuore della mia tesi, in cui ho analizzato “il gruppo come campo di co-costruzione del genere come vissuto”.
Nei gruppi che viviamo quotidianamente – famiglia, amici, colleghi – questa predisposizione alla relazione si attiva. Le interazioni, i corpi che si incontrano, le emozioni che si scambiano: tutto questo contribuisce a modellare il nostro genere, non come un attributo fisso, ma come un’esperienza dinamica e condivisa che si crea e può ricrearsi continuamente.
Perché questa prospettiva sul genere è importante?
Non è solo una prospettiva teorica quella che fornisce l’approccio fenomenologica nella comprensione del genere e che ci permette di riconoscere il ruolo centrale del corpo, sottolineare la nostra natura relazionale, andare oltre gli opposti. Sotto questa lente, si fa più esplicito il significato pratico della riflessione sul genere.
Si pensi alle pratiche di Autocoscienza che nascono negli anni Sessanta/Settanta tra gruppi di donne che sospendono (epoché) lo sguardo maschile e che si rimettono in dialogo attraverso relazioni concrete. Se, come il sesso, il genere è legato a come viviamo e sentiamo il nostro corpo nel mondo, in modo più esplicito il genere si forma e si trasforma attraverso il contatto e l’interazione con altre (e non solo nella dicotomia della differenza). A partire dalla “risonanza” corporea fondamentale è possibile interrompere il “destino” del genere femminile pensato come “dato biologico immutabile”.
Parimenti, a partire dalla possibilità di abitare la soglia della differenza sessuale (che non significa quindi solo “differenza tra sessi”) si può ripensare una co-costruzione di generi non identici o complementari. Ad una costruzione di “genere” linguisticamente arbitraria (statement), può seguire così un legame con la nostra esperienza più profonda di sé e dell’alterità (che Pellegrini chiama “relativo plurale”).
In questa prospettiva la domanda sul genere rimanda ad una domanda ulteriore: come stiamo tra noi?